
DISCLAIMER: il seguente pezzo è frutto di giorni di elucubrazioni, lotte interiori, fermentazione delle viscere e, anche se non vi sembrerà, di molta (moltissima) edulcorazione. È una dichiarazione d'amore per lo sport sotto forma di sproloquio violento e irrispettoso nei confronti della cerimonia di apertura, con accenni di cinismo e sarcasmo a piacere. Se temete di sentirvi offesi, probabilmente lo sarete prima di arrivare alla fine. Proseguite a vostro rischio.
Non vi so dire da dove nasca il mio amore smisurato per le olimpiadi. Forse dai mille sport che ho praticato prima che i grassi saturi avessero la meglio sulle mie molteplici (e ugualmente scarse) carriere sportive; forse da quei giochi della gioventù che in un’epoca ormai lontanissima mi fecero innamorare del salto in alto (qui per ridere dovreste conoscere la mia statura attuale e fare le dovute proporzioni col me dodicenne); forse da mio padre, dal quale ho ereditato l’attrazione magnetica per ogni disciplina sportiva e il vizio delle notti insonni a guardare filmati di repertorio e partite di biliardo in replica su RaiSport; forse da quella volta ad Atlanta in cui Jury Chechi è stato Michelangelo e Raffaello insieme.
Non so da dove arriva questa ossessione passione, ma vivo ogni olimpiade con una devozione e un’idea del sacro che nessuna religione è mai riuscita a trasmettermi nemmeno lontanamente. Guardo ogni gara di ogni sport; dall’atletica alla pallamano, dal tiro a volo all’hockey su prato, con l’unica eccezione del dressage (di cui comunque mi picco di conoscere le regole); pensate alla disciplina olimpica più noiosa che potete e io sarò lì a guardarla con gli occhi sbarrati. Prendo ferie, mi organizzo con schermi multipli per le gare in contemporanea, se serve faccio abbonamenti a Pay TV che normalmente non farei nemmeno se nel pacchetto a 9,99€ fosse compreso Al Pacino che recita dal vivo a domicilio. In quelle due settimane seguo tutto con una dedizione che se avessi mai avuto per una qualsiasi attività remunerativa, probabilmente oggi maneggereste banconote con la mia faccia.
Insomma, tutto questo per dire che venerdì sera ero lì, sul divano, in modalità fantozziana con tanto di Peroni familiare ghiacciata e rutto libero, per ripetere nuovamente il rito. E invece.
Invece per la prima volta nella mia vita non ho visto una cerimonia di apertura delle olimpiadi. Ho guardato tutto, dalle 19:30 fino all’ultimo secondo della diretta Rai, ho ascoltato il commento di quel monumento al giornalismo sportivo che è Franco Bragagna, mi sono commosso insieme al mio metallaro interiore all’uscita dei Gojira, ho invocato Gigi D’Agostino guardando la discoteca galleggiante, ho riso coi filmati dei minions, ma le olimpiadi non si vedevano, non si sentivano, non si percepivano. In più di quattro ore a osservare quel che accadeva lungo la Senna non c’è stato un solo riflesso di De Coubertin, non una sola immagine del mondo intero unito dallo sport oltre i conflitti e le questioni sociali, non un flebile accenno del sacro fuoco di Olimpia. Nulla.
Lasciate che vi risparmi delle grida inutili: non me ne frega nulla delle drag queen e dei lustrini, delle calze smagliate scambiate per testicoli, dell’ultima cena che forse era la penultima o forse era un’orgia di Trimalcione, delle fregole di Salvini e del suo club dello strutto, dei sentimenti religiosi di chicchessia o delle seghe furiose che vi siete fatti sui social sbraitando di satanismo e resa dell’occidente da una parte o facendo le pernacchie a Pillon dall’altra. Non mi interessa nulla dei posizionamenti morali a riguardo, che sono tutti ugualmente sbagliati, tanto quelli che dicono “assomiglia a una cosa a cui da piccolo mi hanno insegnato che devo tenere tantissimo, vergogna!” quanto quelli che applaudono tutto e il contrario di tutto basta che vada di traverso ai conservatori cattofasciociseteropatriarcali. Mi interessano le olimpiadi e il loro spirito, che venerdì sera sono stati presi a pesci in faccia da ogni lato in nome di rivendicazioni che stavano a quel contesto come Giovanardi sta all’onestà intellettuale.
La cerimonia di apertura delle olimpiadi significa presentazione delle delegazioni, centralità dello sport, rivendicazione di equità e celebrazione di unità delle nazioni nell’olimpismo, ma non c’è nessuna equità in una sfilata sulla Senna in cui invece di calcare il medesimo tappeto rosso gli atleti sfilano su barche diverse, di dimensioni diverse, raggruppati come delle comitive in una gita low cost. Non c’è nulla di equo nel veder passare la Germania su uno yacht e il Gabon su un barchino da pesca delle carpe. Non c’è centralità dello sport quando ad ogni delegazione sono stati riservati così poco tempo e inquadrature che a malapena si vedevano i porta bandiera, e perfino quel sant’uomo di Bragagna ha avuto da ridire in diretta. Non c’è olimpismo nell’immagine di un braciere che si accende illuminando solo sé stesso mentre protagonisti e spettatori restano al buio per far venire meglio le foto.
C’è, in compenso, la ricerca dell’effetto scenico e dello spettacolo fine a sé stesso. C’è il tentativo di rendere una cerimonia solenne a dimensione di tik tok, con palchetti sparsi inquadrati per 30 secondi, ché dopo che hai visto un paio di giravolte sulla rampa delle bmx e ci hai fatto una storia su Instagram mica vorrai stare a vedere tutta l’esibizione, cosa sei, un boomer? Quelli sono fior di professionisti che si sono allenati per mesi, ma nulla conta rispetto alle necessità dell’algoritmo. C’è l’inserimento forzato di tutte le istanze che piacciono alla gente che piace, a partire dal capitolo “sororité” accostato a “fraternité” – perché da quando il contesto è morto puoi pure essere il fondamento del diritto universale ma la desinenza maschile è comunque patriarcato e oppressione – passando per l’esecuzione di Imagine che fa tanto pacenelmondo-volemosebbene e l’inclusivismo a campione con un esemplare per ogni discriminazione come allo zoo, fino alle rivendicazioni sessuali tutte, dal queer in giù, a banchettare sulle iconografie aspettando il bruciore di culo dei fasci.
Un enorme minestrone di identitarismo e rivendicazioni sociali coloratissime e taggabilissime e legittimissime e bellissime, in cui però c’è un’unica identità assente: quella olimpica. Il filo conduttore di quattro ore di cerimonia è stato la mondanità esasperata, e ognuna di quelle singole esibizioni – singolarmente eccelse e ben eseguite, per fortuna – è stata pensata in funzione del trend, della riuscita televisiva, del live twitting, del posizionamento sociale su Reddit; in funzione di tutto tranne che del contesto olimpico, relegato alla fiaccola inquadrata di tanto in tanto e un paio di comparse travestite da divinità antiche, giusto per poter dire “Grecia!” e mettere il segno di spunta su quella rottura di coglioni dei riferimenti storico-culturali, per poi tornare a occuparsi delle cose che prendono tanti like.
Non c’era nulla nemmeno del paese ospitante. Un paese con secoli di storia e tradizione da raccontare al mondo ridotti a un collage di cartoline che i tecnici di Blob con 30.000 lire lo facevano meglio, per poi dare spazio al bisogno di tendenza, a fare “quel che vogliono si sappia in giro fanno” e dichiararsi ossessivamente qualcosa che non sono, ma devono giurare di essere se vogliono l’indotto degli sponsor e i cuoricini dei buoni. Buoni che nel frattempo celebravano l’inclusività urlando “dovete morire di reflusso” a tutte quelle identità che evidentemente non hanno diritto alla stessa cautela riservata a chi pretende la testa dei comici per una battuta su un taglio di capelli. Buoni che per farsi un’idea di quel che vedono hanno bisogno di un’etichetta da assegnare e di conoscere l’opinione della curva opposta.
Buoni che – in quella stessa Francia che giurano essere tutta inclusività, amore libero e rave dissacranti – nel mondo reale un mese fa hanno rischiato di farsi governare dall’ultradestra razzista e xenofoba, alla faccia di lustrini e baccanali pagani.
Non ho perso una sola cerimonia olimpica da che ho memoria, e quella di venerdì è stata senza alcun dubbio la peggiore di tutte. Non perché non ci fosse lo spettacolo, e nemmeno perché me ne freghi qualcosa dei sentimenti di chiunque si senta offeso da qualsiasi cosa avvenga su un palcoscenico. È stata la peggiore perché anonima e artificiosa, bugiarda nel raccontare il paese ospitante nascondendo lo sporco sotto il tappeto come nemmeno il carnevale di Rio coi desaparecidos, talmente slegata dal contesto olimpionico e schiava della logica dell’happening che potrebbe essere replicata per inaugurare indistintamente i mondiali di calcio o la settimana della moda, la première dell’ultimo film Marvel o il nuovo yacht di Briatore, un apericena in casa Ferragni o i festeggiamenti di un prediciottesimo a Napoli.
Il mondo, soprattutto oggi, meritava un rito collettivo e ancestrale, forse l’ultimo rimasto ad una società che permette i sold out di Sfera Ebbasta a San Siro senza intervenire militarmente; l’unico rito profondamente laico in un guazzabuglio di fondamentalismi malati di predominio. Ma nel paese di Carlo Martello, più dell’onor potè il pressapochismo. Il pressapochismo di chi ha deciso che l’inaugurazione delle olimpiadi e un after party di Versace potessero rispondere agli stessi bisogni. Il pressapochismo di chi, nel sensibilissimo occidente, silura i telecronisti per le battute sceme ma non spreca 10 minuti a cercare il brano giusto e suona l’inno del Sudan di fronte agli atleti del Sud Sudan, alla faccia delle due sanguinosissime guerre civili con cui il paese di quegli atleti si è guadagnato l’indipendenza. Il pressapochismo di chi – essendo abituato a gente che annuisce per non fare brutta figura di fronte alle supercazzole con cui gli stilisti giustificano una giacca con le tasche sulla schiena – ha prima rivendicato orgogliosamente l’ultima cena queer che scardina i pregiudizi, per poi ritrattare e dire che no, era una tavolata dionisiaca, anzi no, era una citazione di un antichissimo quadro ormai perduto di un pittore afro-islandese trans del ‘500 perseguitato dagli antenati della Le Pen, anzi no, era un normalissimo mercoledì sera in casa Malgioglio.
Potrei andare avanti per altri trenta capoversi a elencare gli errori di una cerimonia sbagliata dalle fondamenta, e l’avrei anche fatto, ma poi, per fortuna, lo sport arriva dove la politica e le rivendicazioni vuote non sanno andare: i giochi iniziano e gli sconfitti applaudono i medagliati, i vincitori per abbandono consolano gli avversari infortunati, le nuotatrici che mancano la medaglia di un centesimo piangono comunque di gioia in barba alle obiezioni giornalistiche, e mentre finisco di scrivere questo faticosissimo travaso di bile – che vi assicuro essere edulcorato – atleti delle due Coree posano abbracciati per una foto dal significato enorme.
C’è una fiamma che non è passata per le mani di Snoop Dogg, una fiamma che non sta in quell’obbrobrio a forma di mongolfiera e supponenza, una fiamma che sa ancora dominare sui bassi istinti, sospendere le guerre e superare le questioni puerili con cui ci trastulliamo sentendoci migliori degli altri. C’è una fiamma che resiste, nonostante il pressapochismo francese. Nonostante i giornali stiano già titolando “il selfie coi nemici di Seul”. Nonostante gli intolleranti al contesto pensino di possederla o imprigionarla in un’etichetta in nome di chissà che. Nonostante la Senna e i suoi batteri. Nonostante le pailettes. Nonostante i religiosi. Nonostante voi. Nonostante me.
Citius, Altius, Fortius.





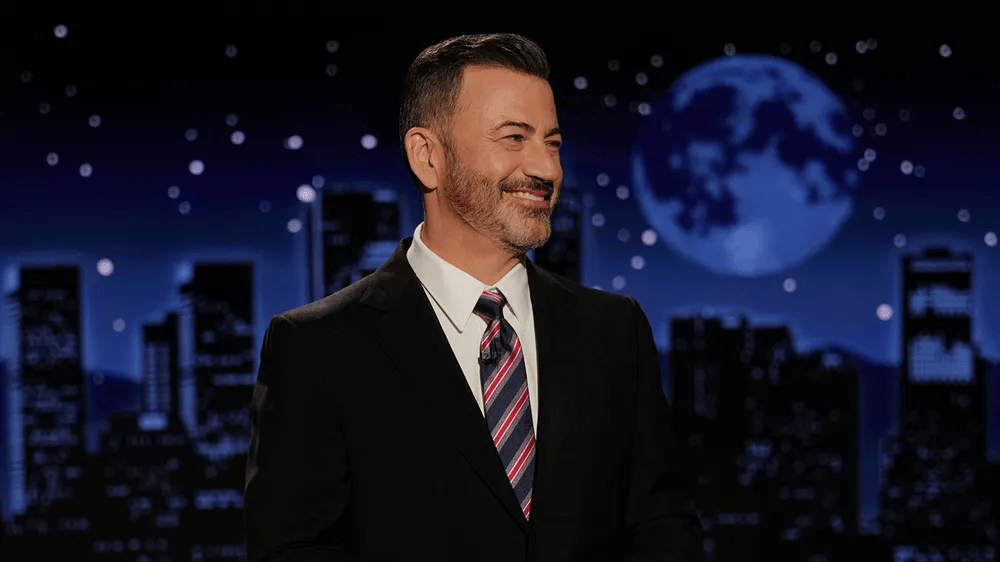
Lascia un commento