
L’Italia è ciò che accade mentre spettegoliamo d’altro. Comincio questo pezzo che avevo in testa da giorni (e che una forza misteriosa che chiameremo “Non sarò mai bravo come Luca Bizzarri” mi ha trattenuto dallo scrivere finora) parafrasando John Lennon, e lo faccio per tre ragioni. La prima ovviamente è darmi un tono, millantando una ricerca intellettuale dietro le pernacchie per distinguermi da quelli più bravi di me dalla satira mainstream; la seconda ragione è che non c’è niente di più italiano di tirare in mezzo i morti in un discorso che non li riguarda, tanto per quelli che hanno riesumato Berlusconi per dare del dilettante a un ministro travolto dalla visione della figa da vicino, quanto per quelli dall’altra parte che pur di trovare un’equivalenza a sinistra sono riusciti a paragonare le barzottate tristi di Sangiuliano e Boccia con la storia tra Togliatti e Nilde Iotti (senza essere colti da ischemie o attacchi epilettici, e ciò dimostra l’imperfezione del corpo umano, altro che macchina perfetta).
La terza ragione è che la sceneggiatura comica vicenda infelice dell’ormai ex ministro della cultura inizia proprio con quei “progetti” che ci ostiniamo a fare mentre la vita vera scorre fregandosene inesorabilmente. Tutto inizia con Gaetano Maria Barbagli Giorgia Meloni che chiama a raccolta il governo dicendo “stiamo facendo la storia, non sono ammessi errori” e, prima di proseguire nell’ovvia trama monicelliana, conviene chiarire una cosa: “fare la storia” è la fissa di quelli che la storia non l’hanno mai nemmeno studiata, figuriamoci esserne parte cosciente. La pretesa di star lasciando un segno nella storia è l’ultimo rifugio degli incapaci, che più sono incapaci più enfatizzano i discorsi, più sono ininfluenti e più raccontano di poteri oscuri e trame nell’ombra a loro danno, più ce l’hanno piccolo (lo spessore istituzionale) più insistono a tirare fuori la faccenda del chiodo e del martello.
Quale impatto ha sulla “storia” la caduta pub(bl)ica di Gennarino nostro? Che utilità hanno realmente le sue dimissioni? Nessuna. Assolutamente nessuna. Non ne hanno perché la stessa nomina di Sangiuliano non ne aveva, e a dimostrarlo c’è non tanto il background agghiacciante del suo sostituto (per il quale il mondo della comicità sentitamente ringrazia in anticipo) quanto il fatto che il suddetto sostituto fosse già pronto ai blocchi di partenza, fuori uno e dentro l’altro senza soluzione di continuità, come gli operai generici in catena di montaggio. Per questo faccio fatica a reggere i discorsi pomposi di quelli che chiedevano a gran voce le dimissioni di Sangiuliano: per ottenere cosa? Davvero pensate che il problema di quel ministero fossero gli ormoni malgestiti del ministro? Se Sangiuliano era il titolare, chi vi aspettavate dalla panchina? Barbero? Il fantasma di Arbasino? Stefano Bartezzaghi?
Fine della precisazione, altrimenti qui facciamo notte. La vicenda, dicevo, inizia con la Meloni che, piantando bandiera sul suolo marziano dettando la linea ai suoi, li sprona a non compiere errori che potrebbero mettere in cattiva luce il finora impeccabile operato del suo governo. Già qui si ride tantissimo, con la premier che si lancia nel discorso da condottiera credendosi William Wallace da Elderslie e dimostrandosi invece Brancaleone da Norcia, ma tutti noi sappiamo che la scena madre è ancora lungi dall’arrivare. Inizia l’affaire Sangiuliano e più se ne parla più io penso alla pergamena di Taccone e Mangoldo, penso a Teofilatto dei Leonzi, penso “adesso sì che si ride”. Penso a quel verso di John Lennon, ironicamente scritto nel 1980, dopo la galeotta Maria Rosaria Yoko Ono, dopo la crisi del governo dei Beatles, e poco tempo prima della venuta di Alessandro Giuli Mark David Chapman.
Penso a Oliviero Toscani che dice senza mezzi termini che l’italianità è Fabrizio Corona, mica Jannik Sinner. Penso che nulla mi fa sbellicare quanto i cronisti che credono sensato fare paragoni con Clinton e la Lewinsky in una nazione di cui l’inaffidabilità del potere e l’infedeltà coniugale sono dogma incontestabile dai tempi di Marziale. Penso che se mai ce ne fosse fregato qualcosa della serietà istituzionale Selvaggia Lucarelli lavorerebbe in un centro estetico, l’aeroporto di Malpensa non avrebbe quel nome lì, e Sgarbi sarebbe al massimo la controfigura di Alec Baldwin per le scene di violenza verbale.
Penso, mentre si discute di “ius” farraginosi e cittadinanze da meritare, che non esiste tratto italico più evidente della propensione al pettegolezzo mentre la storia scorre e, giacché scorre comunque, almeno non sprechiamo energie a prenderla sul serio. Che ci frega dell’accesso ai documenti, dell’uso improprio dei soldi pubblici e di tutte cose? La Boccia ha insinuato ci siano ricatti ben più gravi e la reazione generale è stata “Ok, ma vi mandavate foto hard su Telegram?”. A noi interessano le corna, le foto compromettenti, le liti con la moglie; ci interessa il sexting su WhatsApp, vogliamo le foto del cazzo in chat sbattute sulla prima pagina, vogliamo Alvaro Vitali e Gloria Guida, vogliamo sapere se poi alla fine la Boccia è stata Edwige Fenech o Anna Mazzamauro, vogliamo il nome di chi ha lasciato al ministro la cicatrice sulla fronte su cui ci siamo concentrati mentre lui singhiozzava in TV. È stata la moglie? È stato il geometra Calboni? Paul McCartney? Voldemort? Non teneteci sulle spine, ché ci impazzisce la maionese!
Dopotutto siamo il paese di Paparazzo e del Conte Mascetti, non è gossip, è una questione – questa sì, altro che Dante e il pensiero di destra – di identità culturale. Siamo l’Italia della grande commedia e lo siamo sempre stati, non date retta a quelli che si ostinano a distinguere gli scuri di Caravaggio dai controluce di Tinto Brass; il problema, semmai, è che abbiamo smesso di produrre registi all’altezza. Oggi che Scola, Risi, Monicelli o Villaggio non ci sono più, oggi che del Cioni di “Onda Libera” non c’è traccia nel Benigni che scrive omelie per il Papa, oggi che qualcuno ci ha detto che dobbiamo commuoverci per il film della Cortellesi e inorridire per quelli della Wertmüller sennò vince il patriarcato, oggi che nessuno trasforma più i nostri difetti in magia su pellicola è naturale che la politica si mostri per il materiale grezzo e insensatamente smanioso che è sempre stato.
Chi è Sangiuliano, in fondo, se non un personaggio perennemente in bilico tra il giudice di De André e Pasqualino Settebellezze? E cos’è quello di Maria Rosaria Boccia se non un grande ruolo tristemente orfano di una Monica Vitti che gli renda giustizia? E certo, a voi il gossip non interessa, figuriamoci; voi guardavate solo i film di Maselli e Lizzani, voi siete profondamente preoccupati per la tenuta della democrazia, per il nostro conclamato prestigio internazionale macchiato dalle fantasie turgide del ministro e per la lesa dignità delle cariche ministeriali, ma fingiamo per un attimo che non abbiate questioni irrisolte con le versioni di greco del ginnasio.
C’è, in questa vicenda comicamente torbida o viceversa, la sceneggiatura che Woody Allen ha goffamente e inutilmente rincorso per tutta la vita. C’è, come per quel famoso discorso di Farinetti sul cibo, l’intero patrimonio a cui siamo atavicamente predisposti e che ci rende inimitabili nel mondo. C’è la dimensione umana della politica, fatta non soltanto di ideali e uomini ligi al sacro fuoco della democrazia, ma anche e soprattutto di ministri che da ragazzini scopavano pochissimo e covavano risentimento; c’è la scena delle dimissioni, che in qualsiasi altro paese del mondo sarebbe un drammatico gesto dovuto mentre da noi è il finale comico già scritto con tanto di sintassi martufelliana; c’è l’affanno dei vassalli nel mostrarsi più vassalli degli altri; ci sono gli addetti alla sicurezza del Parlamento, immagino distratti da una scollatura generosa, che non si accorgono di un paio di occhiali con telecamera e lucina accesa.
C’è – apoteosi della commedia italiana – il lessico fantozziano in ogni suo aspetto: la Boccia che inizia le telefonate con “mi sono interfacciata” perché “ho parlato” è da boomer, Feltri che parla di “pucchiacca” come Francesco Salvi parlava del diesel, Sangiuliano che racconta baldanzoso di ipotetiche chat bollenti e 30 secondi dopo chiede scusa in lacrime alla moglie, Madonna Giorgia coi suoi consigli da chioccia-influencer che gli suggerisce “dì sempre la verità e sii sempre sincero” (se a questo punto non state pensando a Sandra Milo per il ruolo da protagonista di “Sono Giorgia, la fiction” non possiamo essere amici), e poi la “pompeiana esperta” evocata da Mieli l’intellettuale, la lettera di dimissioni sgrammaticata del ministro, ma soprattutto – Woody Allen, prendi appunti sul linguaggio – il mantra de “La Dottoressa Boccia” ripetuto in ogni dove, dalle conversazioni telefoniche cortesi dei funzionari fino agli opinionisti che le danno della troia nei talk show, con la naturalezza del lessico endemico, delle formule condivise, degli “scusi geometra”, “mi permetta ragioniere”, “Signorina Silvani, posso avere l’onore di averla a colazione da Gigi il Troione?”.
Più riguardo i tratti di questa vicenda e più mi fanno ridere quelli che ci si incarogniscono prendendosi sul serio; più sento le opposizioni urlare allo scandalo indicibile e più mi convinco che questi governeranno in eterno; più vedo i social impazzire ad ogni dettaglio aggiuntivo più capisco che anche questa bolla – come tutte quelle di poco conto a cui affidiamo il sol dell’avvenire per un quarto d’ora – è destinata a cadere nel dimenticatoio senza un solo erede di Comencini a raccoglierne le scorie per trasformarle in cinema. In tutta questa faccenda un pericolo concreto per la cultura esiste, sì, ma non ha niente a che vedere con le lenzuola umide del ministro: abbiamo esaurito i registi all’altezza del materiale che abbiamo a disposizione.
Manca il ricambio generazionale, e se oggi, dopo 50 anni, siamo costretti a citare Monicelli e Scola, saremo costretti a rifarlo tra altri 50, perché nel mezzo di quel secolo di distanza ci saranno – come ci sono ora – fior fior di registi impegnati, giornalisti indefessi e capi dell’opposizione inorriditi, tutti concentrati a ignorare Lennon e fare progetti mentre la vita va per conto suo; tutti a giurare che è finito il tempo dell’amichettismo di sinistra della commedia leggera ed è arrivato quello dell’egemonia fascista dell’impegno; tutti a raccontare il profondo bisogno di un cinema che lanci i giusti messaggi; tutti con la fissa di “fare la storia” su Marte mentre l’Italia accade, in tutta la sua sempiterna italianità, e tutti quei “mai più” andranno perduti nel tempo, come lacrime al TG1.
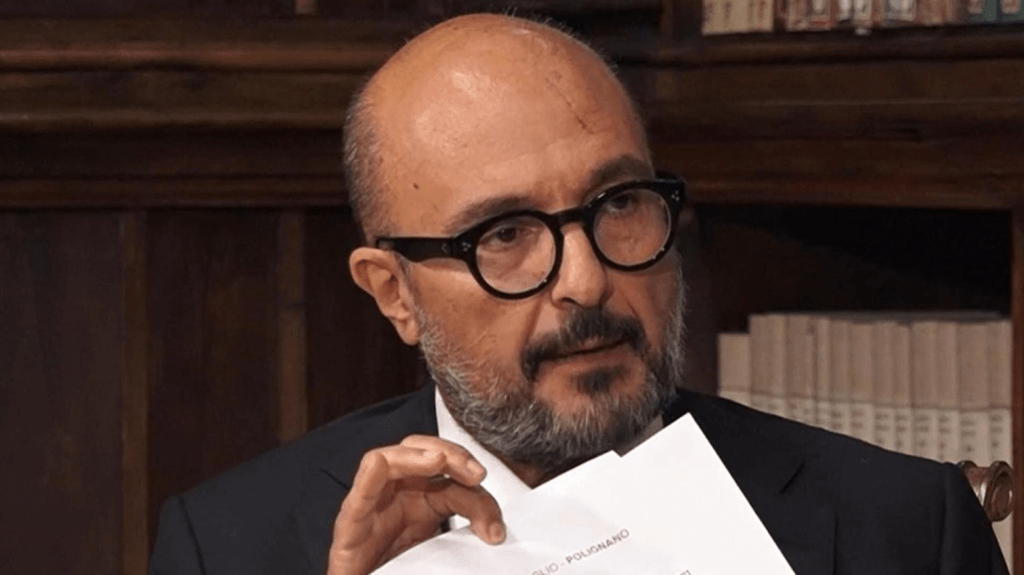





Lascia un commento